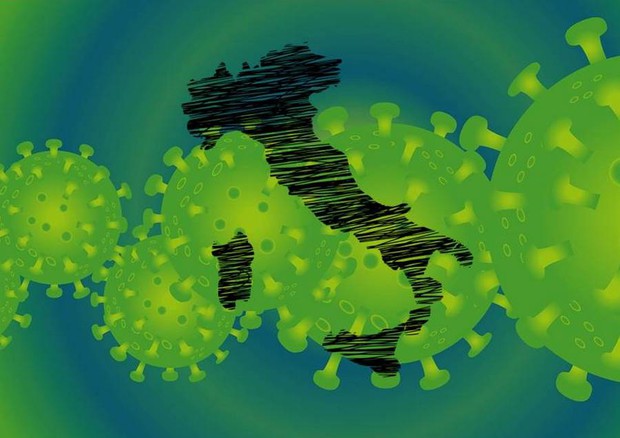Il 20 febbraio viene diagnosticato all’ospedale di Codogno il primo caso di Coronavirus in Italia, grazie all’intuizione dell’anestesista Annalisa Malara che ha anche dovuto combattere contro la burocrazia per poter fare un tampone al paziente dal momento che il protocollo contro Covid-19 prevede semplicemente di chiedere ai pazienti se erano stati in Cina o avuto rapporti con persone tornate da là. Nel frattempo il paziente 1 era stato trattato come affetto da comune polmonite e senza alcuna protezione speciale, anche perché solo tre giorni prima ancora eminenti virologi televisivi proclamavano con una certa sicumera l’assoluta impossibilità della presenza del virus in Italia. Settimane dopo, diversi sanitari delle strutture ospedaliere del Basso Lodigiano ma anche di Parma e altre città, hanno rivelato di aver registrato un numero anomalo di casi di polmonite già dalla metà di gennaio. Tirando le somme, tra il 18 febbraio (primo ricovero) e il 20 febbraio (diagnosi), il paziente uno viene a contatto, non protetto o scarsamente protetto, con un numero elevatissimo di medici, infermieri e, probabilmente, pazienti in attesa al pronto soccorso.
Il 22 febbraio viene istituita la cosiddetta zona rossa nel Basso Lodigiano, tuttavia l’ospedale di Codogno non viene disinfestato: in medicina e terapia intensiva, restano malati a pochi metri da chi ha il virus e la bonifica è, dicono, “sospesa”. Ugualmente, non si tracciano persone che sono transitate dal focolaio, in particolare il famoso pullman che ha portato decine di ballerini alla discoteca Impero l’8 febbraio, quello che poi porterà il virus in Emilia Romagna e altre zone d’Italia.
Il 23 febbraio si registrano i primi due casi positivi all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, Val Seriana. Il nosocomio viene chiuso per alcune ore, poi per qualche oscura ragione viene riaperto. Il sindaco Camillo Bertocchi oggi: “Nessuno ha mai spiegato perché è stato riaperto, poi il virus si è sparso per le valli”. Fatto sta che da lì parte il terzo focolaio del virus (quello di Vo’ Euganeo è l’unico rimasto sempre sotto controllo) che sta mettendo in ginocchio la Bergamasca.
Il 25 febbraio, dopo che i possibili contatti con il paziente uno (dipendente di una multinazionale, maratoneta e calciatore) sono stati tracciati e testati a tappeto, il Presidente del Consiglio Conte dichiara: “Con i tamponi per il coronavirus abbiamo esagerato”, Walter Ricciardi, membro dell’OMS e neo-consulente del Ministero della Salute, chiede che il “grande allarme”, che comunque non va “sottovalutato”, sia “ridimensionato”. Due giorni dopo, e siamo al 27 febbraio, lo stesso Ricciardi imporrà lo stop ai tamponi a chi non presenta sintomi mentre, negli stessi giorni, Franco Locatelli direttore del Consiglio superiore di Sanità dichiara che “il rischio contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici”; tempo dopo la rivista Science stimerà la percentuale di contagi derivanti da casi non documentati (asintomatici o presintomatici) nel 79 % dei casi. Ovviamente esplode il numero di asintomatici positivi.
Sempre il 27 febbraio, dopo solo tre giorni di chiusura parziale delle attività, il sindaco di Milano Giuseppe Sala lancia l’hashtag #MilanoNonSiFerma (imitato da altri, su tutti il sindaco di Parma Federico Pizzarotti preoccupato per Parma 2020) per rilanciare la circolazione delle persone, la frequentazione di negozi, bar, ristoranti, attività. Il segretario del PD Nicola Zingaretti raccoglie l’appello e si fa riprendere a fare un aperitivo sui Navigli. Sappiamo come è finita. Contestualmente il leader della Lega Matteo Salvini fa un video per invitare il Governo ad aprire tutto.
Il 2 marzo la situazione nei comuni della Bergamasca di Alzano Lombardo e la confinante Nembro è drammatica, i contagi e i decessi si moltiplicano. I sindaci e il governatore della Lombardia chiedono a gran voce l’istituzione di una nuova zona rossa nelle valli bergamasche da affiancare a quella del lodigiano. Il 6 marzo, quattro giorni e moltissimi contagi e decessi dopo, il Governo, riportano gli organi di stampa, “sta ancora pensando” se istituire una zona rossa in Val Seriana. Non lo farà.
L’8 marzo (o meglio, la notte tra il 7 e l’8 marzo) il Governo emana un nuovo decreto che istituisce un’unica grande zona rossa in Lombardia e altre zone rosse in 14 province tra Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche. La sera precedente viene fatta circolare (ancora non è chiaro da chi: portavoce del premier? Regione Lombardia?) una bozza del decreto che arriva in tutte le redazioni, su tutti i siti web, in tutte le chat di Whatsapp. Spaventate dall’idea di non potersi muovere per settimane, centinaia di persone si affollano sui treni, su pullman, auto private e addirittura taxi per “scappare” dalla zona rossa e arrivare al sud. Il 15 % di quelle persone parte con febbre alta, gran parte di queste sono dirette in Puglia dove contageranno genitori e famigliari.
L’11 marzo il decreto che limita movimenti e attività viene esteso a tutto il Paese: l’Italia diventa un’unica enorme zona rossa. Gran parte dei governatori della regione del sud impone l’obbligo di autocertificazione per chi proviene dalla Lombardia o altre zone “ex rosse” e quarantena in isolamento domiciliare. Questo però non impedisce il contagio di parenti conviventi.
Il 15 marzo alla stazione di Salerno viene eseguita dagli operatori del 118 guidati dal medico dottor Massimo Manzi un’ispezione del treno 561 Roma Termini – Reggio Calabria. Risultano presenti nove passeggeri con febbre sopra i 37,5 e forte tosse, quasi tutti erano provenienti dal nord Italia e non erano stati controllati né in partenza, né alle stazioni successive, né a Roma. Fino a Salerno. Vengono raggruppate in isolamento in un unico vagone e fatte proseguire.
Poi se oggi, 20 marzo, abbiamo avuto 627 vittime, potete comunque dare la colpa alle passeggiate.